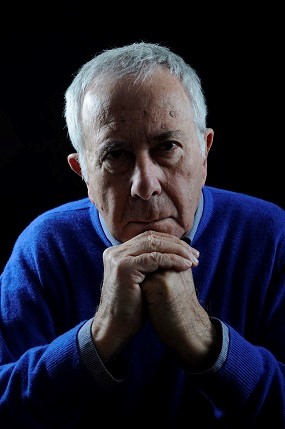 Zaccaria Gallo
Zaccaria Gallo
MOLFETTA - “Quindici” accoglie l’invito di alcuni lettori della rivista che ogni mese è in edicola a Molfetta, a pubblicare sul web, dopo qualche mese, alcuni degli articoli apparsi sul cartaceo, per renderli fruibili a un numero maggiore di gente, soprattutto quando i loro contenuti consentono spunti di riflessione utili alla crescita complessiva.
Lo abbiamo fatto anche in passato, lo stiamo facendo anche ora. Riportiamo oggi l’articolo con cui Zaccaria Gallo ha iniziato la sua collaborazione con “Quindici” e che apre un dibattito fra i lettori e gli intellettuali su politica e potere
Politica e cultura: consenso o dissenso?
di Zaccaria Gallo
Il 31 dicembre 1924 è una di quelle giornate fredde, rigide, tipiche dell’inverno a Firenze. C’erano state, in verità delle avvisaglie su quello che poi sarebbe accaduto, ma nessuno pensava al peggio. Certo, minacce, insulti, provocazioni, qualche scontro verbale nelle settimane e nei giorni precedenti, ma tutto riconducibile al clima incandescente che stava attraversando buona parte del Paese. Il “Circolo di cultura” fondato nel 1920 da Piero Calamandrei e organizzato con Gaetano Salvemini e i Fratelli Rosselli viene assalito da una banda armata di squadristi fascisti. Sono ormai gli anni del fascismo, che impone agli studiosi "appartati nelle biblioteche" di "alzare la testa dai libri" e di "affacciarsi alle finestre”: questo Circolo che si interessa di letteratura, economia, di moralità politica, in sostanza è uno dei primi nuclei di resistenza che chiama gli intellettuali a scendere in campo. Quel giorno le squadre fasciste salgono sul Circolo, lo devastano, prendono gli scritti, i documenti, i libri e li buttano dal ponte di Santa Trinità per poi dar fuoco a tutto.
IL FASCISMO INIZIA LA SUA STORIA BRUCIANDO I LIBRI.
Piero Calamandrei non dimenticò questo episodio: se ne ricorderà anni dopo, quando, membro della Costituente, volle inserire, in un articolo apposito, la parola cultura nella Costituzione repubblicana. Quell’insieme di valori, conoscenze, credenze, norme, linguaggi, comportamenti e oggetti materiali condivisi da una collettività e trasmessi da una generazione all'altra. Quella stessa parola che il Bauhaus descrisse come catalizzatore di creatività nella quale riveste una centralità assoluta. Fonte di ispirazione e di conoscenza, cui attingere, per allargare le esperienze. Strada da percorrere per abitare in maniera consapevole la complessità e arrivare a stabilire il senso dell’essenziale in situazioni di incertezza e di inquietudine. Ricostruzione di un mondo in cui molte generazioni prima di noi hanno vissuto, sognato, immaginato e che riannoda continuamente i fili fra presente e passato, fra generazioni, fra popoli, col risultato di consegnarci a una permanente odissea umana. Avventurosa e affascinante. Che ripensa sé stessa continuamente, senza essere ripiegata sul passato, semmai attenta a quello che siamo stati, per capire quello che siamo oggi e quello che stiamo diventando. E non solo.
LA CULTURA È ANCHE POLITICA.
Per avviare una seria riflessione su quest’ultima affermazione è necessario dare uno sguardo alla situazione attuale nella quale è immersa la nostra vita.
Da tempo, a mio modo di vedere, abbiamo perduto un’interiorità per divenire aridi strumenti del regnante gioco dell’esteriorità conformistica che, a sua volta, è il presupposto di una corruzione del senso identitario di ognuno di noi. Probabilmente è superfluo sottolineare che stiamo attraversando un periodo molto complicato, che il principio di queste due decadi sia all’insegna di piccoli e grandi sconvolgimenti, di situazioni che eravamo ormai abituati a dare per scontato.
Il dibattito culturale è sovraffollato di riflessioni connesse all’attuale scenario: la gran parte collegate al contingente, altre, invece, che provano a elaborare strategie per cercare di scorgere soluzioni per ogni scenario che, sulla base dell’accadere delle cose, diventa più o meno probabile.
In questa moltitudine di informazioni, tuttavia, c’è un elemento che spesso, nel dibattito culturale, viene preso in considerazione soltanto in misura minore, sebbene la sua urgenza sia da ognuno riconosciuta e, soprattutto, sotto gli occhi di tutti: la cognizione del presente da parte dei nostri figli, che è estremamente variegata, all’incrociarsi di super-stimoli con narrazioni, e confusione. Per questo invitare a riflettere su questa condizione di degrado e di ricerca di soluzioni è importante, necessario.
Scenario terribile se ci pensiamo attentamente: conformismo degli ambienti studenteschi, l’affermarsi di una cultura giovanile dello sballo, del menefreghismo, dell’assorbimento della spazzatura consumistica, del perbenismo piccolo borghese, dell’inconsapevolezza, del disamore verso i luoghi della propria appartenenza, dello spegnersi dello spirito ribelle. E su altro versante le vite “separate” di un ceto di professionisti che, della città e delle sue sorti, non si è mai curata, dalla quale si è tenuto fuori, ha badato al proprio “particulare”, ha fatto combriccola, vita a sé, come nelle più squallide ed indecenti congreghe. Purtroppo il mondo della cultura e quello della politica è gonfio di persone più preoccupate a soddisfare la propria attività gastrointestinale, coniugata alle gioie effimere che può procurare loro il denaro, piuttosto che cercare di intervenire per alleviare la sofferenza delle creature più emarginate.
Il vero nemico della cultura, avversario pericoloso per la nostra identità di persone dotate anche di cuore e cervello, è l’indifferenza, una “pandemia” che, insediatasi da tempo, ogni giorno si diffonde a macchia d’olio.
IL POTERE DELLA CULTURA NEL CAMBIARE IL MONDO
Per questo mi pare opportuno riandare con la mente a quanto il passato ci ha tramandato e insegnato sul potere della cultura di poter cambiare il mondo anche nelle condizioni più disperate.
? Prometeo – mito ripreso da Eschilo nel suo “Prometeo incatenato” - che fonda la nozione antropologica di cultura. ? lui che porta agli uomini il fuoco e i farmaci, insegna a leggere i segni della natura; che uomo, poi, vivendo in società, forgerà con il sapere, per contrastare malattie, interpretare il mondo, padroneggiare tecniche e agricoltura, spostare il limite della morte.
Platone in “Protagora” segna il limite che Prometeo non deve superare: tutto deve farlo per l’utilità della società e non per utilitarismo dei mercati (ecco un primo segnale di incontro tra cultura e politica). Su questo piano Prometeo non è assolutamente in rivalità con Zeus. Prometeo non pensa affatto di diventare re e dunque non entra mai, per questo motivo, in competizione con Zeus. Il mondo creato da Zeus è un mondo della ripartizione, un universo gerarchizzato, organizzato in gradi, sulla base di differenze di condizione e di onori. Prometeo appartiene a tale mondo, ma vi occupa un ruolo molto difficile da definire. In una oscillazione fra l’ostilità e la concordia con il sovrano. In poche parole, si potrebbe dire che Prometeo esprime in questo universo ordinato la contestazione interna. Non vuole assolutamente prendere il posto di Zeus ma, nell’ordine da lui stabilito, rappresenta questa piccola voce della contestazione.
Per Democrito se la gioia, da identificarsi non nel possesso di beni materiali, nel prestigio o nel potere, è lo scopo della vita, essa si raggiunge con la moderazione e la cultura odiando tutto ciò che è violento e passionale. Democrito rappresenta un momento d’innovazione nella cultura greca. Infatti libera gli inizi della civiltà da concezioni mitologiche, riconoscendo all’uomo un ruolo da protagonista nella storia e mostrando come la civiltà sia un progresso che va conquistato giorno per giorno con sacrifici e conoscenze. Compito dell’uomo è conoscere scientificamente tale realtà, per giovarsene mediante le applicazioni tecnologiche, sì che politica, etica e cultura vanno a coincidere incontrandosi.
LA LEZIONE DI SOCRATE
Nell’Apologia di Socrate, Platone ci narra la fine del filosofo. Socrate fu condannato a morte perché con le sue domande e con la sua ricerca rompeva le scatole al potere. Sicuramente avrebbe potuto salvarsi se fosse rimasto zitto. Senza paura dichiarò invece apertamente che non poteva rimanere zitto perché, senza la ricerca della verità, la sua non sarebbe stata vita. Socrate ci porta nel cuore di quello di cui ci stiamo occupando: ricercava la verità, cercava la giustizia e se la politica si fondava sul consenso, la cultura si poteva e doveva fondare anche sul dissenso. In Apologia, Socrate afferma di non essersi dedicato alla vita politica nel senso istituzionale del termine, perché «non c'è nessuno che si possa salvare, se si oppone autenticamente a voi o a un'altra maggioranza, impedendo che in città avvengano molte ingiustizie e illegittimità, ed è anzi necessario che chi combatte per il giusto, se deve sopravvivere anche solo per un po', rimanga un privato e non si dedichi alla vita pubblica».
Queste frasi, prese isolatamente, potrebbero far pensare che Socrate sia un individualista, interessato solo a filosofeggiare in privato; ma il fatto, contestuale, che Socrate affronti il processo e la morte, e che colga l'occasione, con la sua autodifesa, per attaccare la tirannide della maggioranza e il diritto penale, lo dimostra portatore di una politicità alternativa, che non assorba la libertà della cultura, ma si fondi, piuttosto, su di essa. Socrate rifiuta di chiedere l'esilio (Apologia) perché convinto che il contrasto fra la vita dedicata all'indagine e la comunità politica non sia una questione particolare, limitata al rapporto fra lui e Atene, ma un problema che si riproporrebbe in qualsiasi altra città.
Ma poniamo attenzione anche a un momento di chiara divaricazione storica.
FEDERICO II E LA CULTURA COME STRUMENTO DI GOVERNO
La vicenda federiciana è stata un momento particolarmente felice per la Puglia dal punto di vista artistico e culturale. Sua è stata l'attività guerresca, l’interessamento per la sapienza e lo spiritualismo e idealismo arabo, la rinascita della forma plastica, la caccia, l'arte divinatoria, la ripresa letteraria e l'amore per il mondo classico. La cultura per Federico II non fu fine a se stessa, ma strumento di governo, infatti essa non usciva fuori dalle concezioni politiche, economiche e sociali del Medioevo, ivi compreso il pensiero di un impero universale e dell’ordine piramidale e feudale della società, mirato a consolidare il consenso e la fedeltà di una classe dirigente che garantisse continuità e stabilità al governo.
Le forme di cultura erano, dunque, disciplinate a tal fine, ecco perché le libere manifestazioni, come quelle di mimi e giullari, erano ritenute pericolose: potevano perturbare l’ordine costituito. Esse furono proibite da esplicite disposizioni contenute nelle “Assise” di Messina del 1221, che prevedevano anche pene severe per i trasgressori. La scuola poetica siciliana, che ha notevole rilievo nella letteratura italiana, rientra in questo quadro, infatti essa era costituita da una “élite” cortigiana di funzionari, dignitari e su tutti i letterati regi, che avevano connotati ideologici e politici in linea con quelli del sovrano e che concorrevano con la loro mansione letteraria a dare lustro alla monarchia sveva. Qui la cultura non esprime più il concetto anche di dissenso dalla politica del potere costituito, anzi ne diventa strumento.
I CIRCOLI PUBBLICI INTELLETTUALI DI GRAMSCI
Ma facciamo un grande salto in avanti e avviciniamoci ai giorni nostri. Antonio Gramsci in una delle magnifiche “Lettere dal carcere”, durante la sua prigionia nel carcere di Turi, scriveva che il riscatto dell'Italia liberata doveva partire proprio dalla cultura, tanto che invitava i politici ad attivare, subito dopo la liberazione, “circoli pubblici intellettuali” (una definizione bellissima che praticamente dice già tutto) perché riteneva che il sale della democrazia fosse contenuto proprio nella cultura. Oltre alle scuole Gramsci si chiedeva: quali servizi non possono essere delegati soltanto all’ iniziativa privata e in una società moderna quali devono essere assicurati dallo Stato e degli enti locali come i comuni le province (le regioni diremmo ora)? E si rispondeva facendone breve elenco: il teatro, le biblioteche, i musei di vario genere, le pinacoteche, i giardini e gli orti botanici e tutti quei beni (che oggi con linguaggio moderno definiremmo beni materiali e immateriali) che hanno bisogno dell’interesse di un intervento pubblico a servizio di tutte le comunità di un paese. (? facile oggi porsi subito la domanda: il teatro è considerato un servizio pubblico oggi? Ed è concepibile che in una grande città non ci sia un vero e proprio teatro, oltre quello estivo?).
Antonio Gramsci, scriveva nel 1916, a 25 anni: «La cultura... è presa di possesso della propria personalità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri”. Cultura, non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con altri esseri.
C’è da chiedersi se oggi chi detiene le leve della politica nel nostro Paese sia veramente in possesso di questa capacità. Martin Luther King diceva di credere anche in un principio estremamente importante per gli intellettuali e per il loro rapporto con la politica: che la libertà si conquista ogni giorno e che, se oggi ce l'abbiamo, è perché Socrate la conseguì con la disobbedienza civile e l'indipendenza rispetto al potere.
LA COSTITUZIONE E LA CULTURA
Torniamo alla nostra realtà italiana e per farlo rileggiamo (dovremmo farlo molto più spesso) l’articolo 9 della nostra Costituzione Repubblicana. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni …”.
Il che significa che la Repubblica viene impegnata ad aiutare, anche con finanziamenti, lo sviluppo della cultura (espressione del talento e della sensibilità umani) e della ricerca scientifica e tecnica (espressione dell'ingegno umano) quali mezzi per contribuire al benessere della società della dignità delle persone. Vi è anche la consapevolezza che l'Italia è un Paese unico al mondo, come fosse stato costruito sulla bellezza, per cui la Costituzione chiede di valorizzare il paesaggio ambientale e storico e quindi promuovere la conoscenza dei beni italiani e garantire che tutti possano avere la possibilità di accedervi.
Rientra in questo specifico argomento anche quello della protezione del paesaggio inteso come ambiente naturale, perché da questo dipendono la qualità della vita e la salute delle persone che ci vivono. Purtroppo è storia di tutti i giorni che è sul terreno dell'attuazione che sono destinati a scontrarsi fatalmente politica e cultura, perché è lì che si può e deve avviare il dialogo, ma è anche lì dove è facile che si possa manifestare il dissenso. Dovendosi ricordare a mo’ d’esempio che bisogna intervenire sui beni culturali di una città, cioè su cose mobili e immobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico, paleo etnoantropologico, dai musei, ai monumenti, ai manoscritti rari, tutti beni culturali che sono di diversa tipologia e di diversa proprietà sia dello Stato che di enti territoriali e anche di proprietà privata.
IL RUOLO DEI GIOVANI
Permettetemi una considerazione personale: non soltanto spetta agli studiosi e ai cittadini intellettuali e no di varia età, ma soprattutto ai giovani, l’assunzione di una responsabilità. In particolare proprio i giovani che si proiettano nel futuro devono essere i più interessati a vigilare ed esortare i poteri pubblici, la politica, affinché questa lettera della Costituzione non rimanga morta e operi in modo tale da conservare il patrimonio culturale per loro è per i loro figli.
? di questi giorni, la notizia comparsa su una prestigiosa rivista letteraria riguardante un fenomeno culturale importante che si sta verificando a Milano e al quale è stato dato nome di “case aperte”. Mi riferisco alle tante case che da qualche tempo hanno aperto le porte e hanno ripreso a pullulare di persone che vi si danno convegno. In queste case si può ascoltare musica, si possono leggere libri, gustare versi di poeti, prendere parte alla presentazione di libri, incontrare personaggi che hanno qualcosa di interessante da dire e ci si unisce anche per sostenere comitati che si battono per le cause le più diverse come la difesa dell'acqua pubblica, la democrazia, la libertà di stampa, la cura della città, la pace e altro ancora (astenendosi così, di tanto in tanto, dalle partite di burraco).
Vi ho dato questa informazione perché vorrei ora con la fantasia invitarvi a partecipare a un incontro immaginario, virtuale, tra grandi intellettuali che, come in uno di quei salotti, si sono riuniti per discutere sul ruolo degli intellettuali (quindi della cultura) e della politica.
Concetto Marchesi a proposito dell’articolo 9 della Costituzione ricorda che al momento della sua approvazione si sforzava di raccomandare che le amministrazioni dessero più soldi alle scuole pubbliche piuttosto che alle armi. Questo lui lo diceva negli anni della Costituente. Qualcuno gli fa notare che in questi giorni scorsi, a fronte dello 0,3 % destinato alle Università, è stato dato il 2% delle risorse proprio agli armamenti.
Emanuel Kant interviene e ribadisce il suo pensiero: “La politica non deve tappare la bocca alla cultura, ma deve ascoltarla, così come la cultura non deve prendere il potere del paese: tra politica e cultura ci deve essere sempre aperto un dialogo, un colloquio, un confronto, non una reciproca sostituzione.
Pier Paolo Pasolini si dice d’accordo, ricordando che quando il 14 novembre del 1974 sul Corriere della Sera pubblicò il famoso “Io so, ma non ho le prove”, voleva dire proprio questo: che lui da intellettuale era arrivato a conoscere la verità, ma spettava alla politica, che ne era in possesso, il compito di esibire le prove di quella verità. Il potere politico e il potere della cultura devono assumersi le proprie competenze e responsabilità.
? la volta di Hanna Arendt ad intervenire: si dice convinta che la politica ha in odio la verità soprattutto quando non riesce a impedire agli intellettuali di cercarla e poi di dirla. Ma gli intellettuali hanno il dovere di ricercare e proteggere la verità. E la politica non deve cercare di imbavagliare la cultura offrendo agli intellettuali di far parte delle liste elettorali né d’altra parte gli stessi intellettuali non devono fare solo la parte del “grillo parlante”. Tra le due parti (quella politica e quella culturale) ci deve essere costantemente teso un cavo in tensione, espressione di un dialogo franco, aperto, rispettoso anche di convinzioni contrarie.
LA CULTURA SUGGERISCE, LA POLITICA DECIDE
Norberto Bobbio mostra agli astanti convenuti il suo libro “Politica e Cultura” pubblicato da Einaudi nel 1955: anche lui sottolineava che chi si occupa di politica e chi di cultura fa mestieri diversi e che devono confrontarsi senza che l’uno prevarichi l’altro. La politica ha il compito di decidere, la cultura di suggerire, di approvare ciò che è sorretto dalla verità, di dissentire in caso contrario. Chi studia, legge, si informa, fatalmente è destinato a riflettere, dubitare, ad essere inquieto quando ricerca, ad essere scrupoloso, a non abbandonarsi a soluzioni affrettate, a non sottomettersi supinamente a verità di una sola parte. La libertà di ognuno di noi si dovrebbe basare proprio nell’esercizio della cultura e dello spirito critico.
Nel corso del XXI secolo, di fronte allo strapotere di una possibile/probabile negativa standardizzazione della tecnologia, una politica che non permetta alla cultura di impedire la livellazione di coscienze e cervelli, sarà sicuramente perdente e subalterna. Da un angolo della sala, Don Benedetto Croce asserisce che ognuno di noi può contribuire quotidianamente e nei più vari dei modi a rendere combattiva la lotta per continuare ad essere liberi, senza pretendere che la politica agisca contro la cultura.
COME TENERE INSIEME POLITICA E CULTURA
Si può dunque pensare di poter tenere assieme politica e cultura? Certamente sì, a patto che la politica non pensi di mettere in disparte la cultura emarginandola in accademie o in forum, convegni, incontri ristretti, convinta di poterne fare a meno e non porti i cittadini a rimpiangere le classi politiche del passato.
La cultura è quella forza indipendente che nella nostra epoca può cercare di unire comunità, irradiando idee, chiamando i cittadini a partecipare, per far poi confluire quelle idee verso i canali della politica. Quando parlo di idee voglio riferirmi al fatto che esse sono né più né meno che i semi stessi della politica, quelli dai quali possono nascere uomini e donne adatti a far politica, a prendere decisioni per il bene comune.
Senza cultura è impossibile pensare a una buona politica.
Piero Gobetti raccomandava tuttavia di stare attenti: la cultura non deve essere prerogativa per pochi, ma deve essere patrimonio da estendere a tutti, soprattutto ai giovani di questa nostra Italia, non deve essere imposta dall’alto ma nascere dal basso e trovare lo spazio (il che non appare a prima vista facile) di inserirsi in un quotidiano in continua veloce trasformazione.
Un compito molto importante, a questo proposito, ogni Amministrazione pubblica dovrebbe impegnarsi a svolgere: quello di porre sempre di più una maggiore attenzione alla valorizzazione della cultura nella scuola, di ogni grado e livello e alla continua pervicace opera di diffusione della cultura artistica. Abbiamo bisogno che la gente legga di più (e magari scriva di meno. Lo ha detto Giacomo Leopardi tanto tempo fa: “Si può dire con verità, massime in Italia, che sono più di numero gli scrittori che i lettori, perché la gran parte degli scrittori non legge, o legge men che non si scrive” (G. Leopardi “Zibaldone”).
LEGGERE PER VIVERE
In una lettera del 18 marzo del 1857 indirizzata a Mille Leroyer de Chantepie, Gustave Flaubert dà i suoi suggerimenti: “Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi. No, leggete per vivere”. Per il romanziere francese, dunque, leggere significava vivere.
Se penso a me stesso posso dire di aver vissuto per leggere, tanto è stata preminente e dispotica questa attività.
John Kieran è ancora più perentorio: “Io sono parte di tutto ciò che ho letto” e Helen Exley sostiene che la lettura “potrebbe” cambiare la tua vita.
I libri: pagine pensate, scritte, stampate, rilegate, diffuse, lette, sfogliate, criticate, presentate. Pagine che viaggiano, ovunque, che parlano, raccontano, non forniscono armi ma parole, idee per sognare, dialogare, curare l’anima, libri custoditi, scambiati, da difendere da chi vuole bruciarli, da regalare per fare felici, per far fiorire prati di cultura, contro la paura dell’ignoranza, per dare vita e spazio alla libertà, alla democrazia.
Bisogna riavere una buona dose di utopia, anche di fronte a concrete e inalienabili difficoltà che si profilano facendo un discorso come quello fatto fino ad ora.
IL SENTIERO DELL’UTOPIA
Abbiamo disperato bisogno di uomini e donne che agiscano, lottino, producano idee, si impegnino per dare corpo alle loro visioni.
E mi sia permesso di concludere con l’esempio di un Grande Utopista italiano: il Maestro Claudio Abbado. Col sistema Abreu egli si propose di usare la musica per portare il paese fuori dal degrado culturale e soprattutto per quanto riguarda quello musicale. Il progetto consisteva e consiste nella diffusione dell’educazione e pratica musicale pubblica, con accesso gratuito e libero per tutti. Due capisaldi del modello sono l’inclusione sociale e la ricerca dell’eccellenza artistica. Questi due punti infatti non si escludono: tutti possono partecipare e tutti sono ammessi, a prescindere dal ceto sociale perché tutti possono e devono aspirare all’eccellenza. Le realtà sui cui il Sistema lavora sono scuole, centri sociali e riabilitativi che hanno potuto godere di un intervento non statale, conoscendo purtroppo le lacune dello Stato nel mondo della musica, ma proprio a livello locale o regionale. La musica e la pratica musicale, in particolare, grazie ad Abreu, offrono ancora una volta una possibilità rivolta ai giovani per salvarsi da ambienti di violenza, criminalità e degrado. Perché i benefici della musica non riguardano solo l’uomo ma anche il suo essere, offrendo per qualsiasi problema una via di fuga.
Una visione del mondo futuro che non contenga il sentiero dell’utopia non è degno nemmeno di uno sguardo. “Il progresso altro non è che il farsi storia delle utopie” ha detto Oscar Wilde a proposito dell’utopia, e credo non ci sia bisogno di aggiungere altro.
© Riproduzione riservata